Dentro, fuori e in mezzo.
Può una distopia seriale mettere in luce un dilemma che viviamo tutti i giorni?
Ho visto la serie tv Scissione (Severance, in lingua originale) ormai qualche mese fa, quando ancora reggeva il mio abbonamento Apple Tv+, adesso tristemente in stand by per una saggia decisione di spending review multi-piattaforma.
Si tratta di una perla cinematografica composta da 9 episodi, perfettamente girata e ben recitata, creata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller e Aoife McArdle. Seppur ancora sconosciuta a molti, ha avuto il piacere di essere tanto apprezzata da essere perfino premiata agli Emmy Award 2022. E nonostante il tempo sia passato, e con esso siano passati davanti ai miei occhi altrettanti film e serie televisive, Scissione è rimasto nella mia memoria, soprattutto per il brivido che solo i capolavori possono lasciare, una volta dimenticato tutto il resto.
Non è importante ricordare alla perfezione, infatti, le vicissitudini dei protagonisti, di Mark e dei suoi colleghi, che, per entrare alla misteriosa Lumon Industries, hanno acconsentito ad una procedura di scissione dell’identità, capace di separare i ricordi della vita professionale da quelli della vita privata, che vivono fuori dalle mura labirintiche dei loro uffici. Non è neppure essenziale ricordare le ambiguità, i non-detti e le teorie, di cui è piena questa serie. È invece più intrigante concentrarsi su ciò che questa prima (e presto non unica) stagione ha fatto sedimentare sotto pelle a chi ne è stato spettatore.
A me, in primis.
A spaventarmi di più non è la domanda che sorgerebbe spontanea, dopo una visione di questo genere: se ne avessimo la possibilità, accetteremmo mai di scindere ciò che siamo, facciamo e pensiamo quando ci troviamo sul luogo di lavoro da ciò che siamo, facciamo e pensiamo quando ne siamo fuori? Molto più inquietante è rendersi conto che, in alcuni contesti e con alcune persone nel corso della nostra vita, questa terribile scissione l’abbiamo già operata. Su noi stessi.
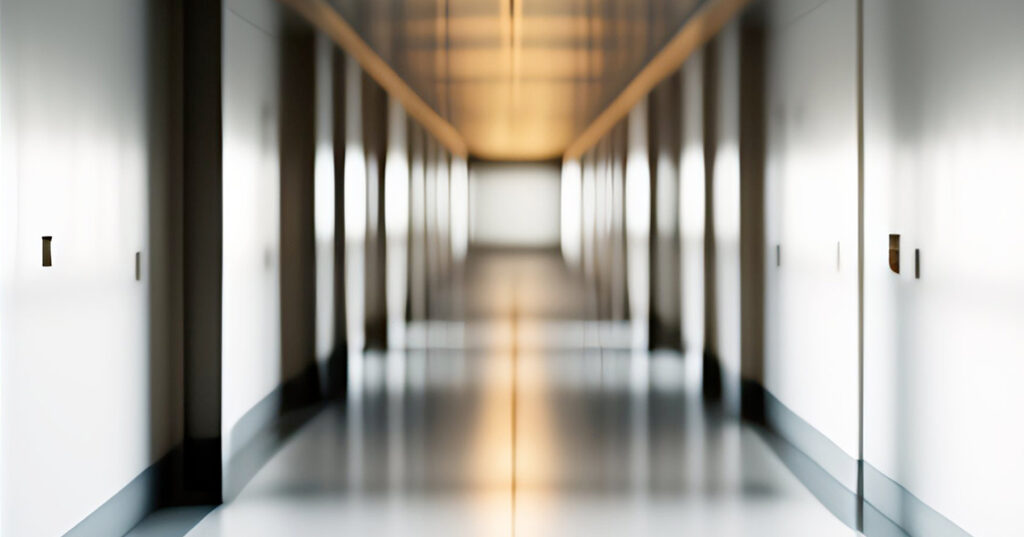
Mai portarsi il lavoro a casa?
Quante volte l’abbiamo detto a qualcuno o ce lo siamo sentiti dire, da un collega sbruffone o da uno che magari tiene alla nostra salute mentale. Io stesso, durante la mia breve carriera lavorativa, ho provato cosa voglia dire “portarsi il lavoro a casa” e quali conseguenze possa avere. Se da un lato far entrare a contatto la sfera professionale con la sfera privata genera un insano piacere da martire stacanovista, dall’altro sposta l’ago della bilancia su impegni, scadenze e sfide di un mondo che non appartiene alla vita “fuori”, che abbiamo il diritto di vivere e preservare in modo distaccato, come entità separata, “scissa” appunto.
Non so se sia rispettoso chiudere la questione così superficialmente, con una frase fatta, che ci allontana dalla paura di sembrare come quell’esemplare raro che, invece di fare aperitivo o andare al cinema, sta scrivendo un articolo per il blog dell’agenzia per cui lavora. Al di fuori dell’orario d’ufficio s’intende.
È così brutto ritagliarsi del tempo per un compito di lavoro e svolgerlo in un periodo di tempo non consono, fuori dalle 8 ore canoniche che compongono la giornata lavorativa standard? La sera magari, quando il mondo sta facendo altro, o, per i più temerari, durante il weekend?
Sacrilegio, lo so. Questa la ritiro, scusate.
Certo, non bisogna esagerare, ma neanche demonizzare.
Meglio fuori che dentro?
La nostra identità sul luogo di lavoro, soprattutto quella “dentro” l’ufficio, è a mio avviso già leggermente diversa dall’identità di “fuori”. Come se entrassimo nella realtà quasi identica di una moderna versione di Attraverso lo specchio, per dirla alla Carroll, non appena mettiamo piede sul pavimento scivoloso della professionalità siamo necessariamente diversi da ciò che siamo stati poco prima: in macchina mentre sorpassavamo la Panda troppo lenta o sul treno che anche oggi era in ritardo, mentre a malincuore parlavamo con la vicina antipatica sul pianerottolo o in ascensore con un inquilino sconosciuto, sotto la doccia a canticchiare l’ultimo tormentone estivo o appena svegli, con poca voglia di alzarci. In poche ore, in questa stessa mattina, siamo stati pigri, smarriti, delusi, socievoli, irritati, preoccupati, spensierati e mille altre sfumature di significato.
La persona che portiamo in ufficio è il risultato di tutte queste emozioni altalenanti, ma è allo stesso tempo una persona “nuova”, che lascia il mondo alle sue spalle – almeno ci prova o è tentata di farlo – e affronta di petto individui, missioni e obiettivi con un’attitudine, sempre in teoria, più incline alla vita sociale, al rispetto dei ruoli gerarchici e alle attività lavorative.
Quanto di noi mettiamo in quello che facciamo al lavoro? Quanto, invece, nascondiamo di noi agli altri? Dove sta il limite tra le due “persone” e c’è davvero questo limite? Siamo noi a imporcelo oppure è solo il rapido riflesso di una struttura che è stata costruita così, ancora prima della nostra assunzione? E che forse oggi non regge più?

La verità sta nel mezzo?
I protagonisti di Scissione hanno permesso che un microchip separasse la loro vita “dentro” dalla loro vita “fuori”. Eppure, mentre vivono perennemente chiusi in azienda e allo stesso tempo, in un tempo diverso e lontano, vivono fuori assieme a tutti gli altri, ma senza averne memoria, cercano disperatamente un senso “unico”: sono alla ricerca dell’unione delle due sfere, professionale e privata, che sono state scisse così nettamente.
Forse non c’è una morale come nelle fiabe, e nemmeno una lezione da imparare. Tuttavia, se un senso vero c’è, quello deve stare proverbialmente nel mezzo.
Un luogo di lavoro sano permette a chi lo vive di portare dentro molte delle cose che stanno fuori: un aneddoto divertente capitato a qualche amico, le avventure serali del proprio animale domestico, un gioco da tavolo da poco in commercio, la scoperta di una canzone, di un film o di un libro, la mostra d’arte a cui vorrebbe partecipare, quella brutta pubblicità che ha visto ieri in televisione, la lista dei nomi che vorrebbe dare a suo figlio, una pianta grassa che non ha bisogno di acqua.
Se per questo dilemma, che tutti i giorni ci attanaglia, tra la spinta a nascondere la nostra vera identità e il fortissimo desiderio di esprimerla, non ci dovesse essere una soluzione, auguro a chi legge un’unica cosa: trovare un posto nel mondo in cui dentro e fuori si possano mescolare il più possibile, in modo spontaneo, divertente, libero.
copiaincolla aspira di certo ad esserlo e, almeno per me, lo è già.

